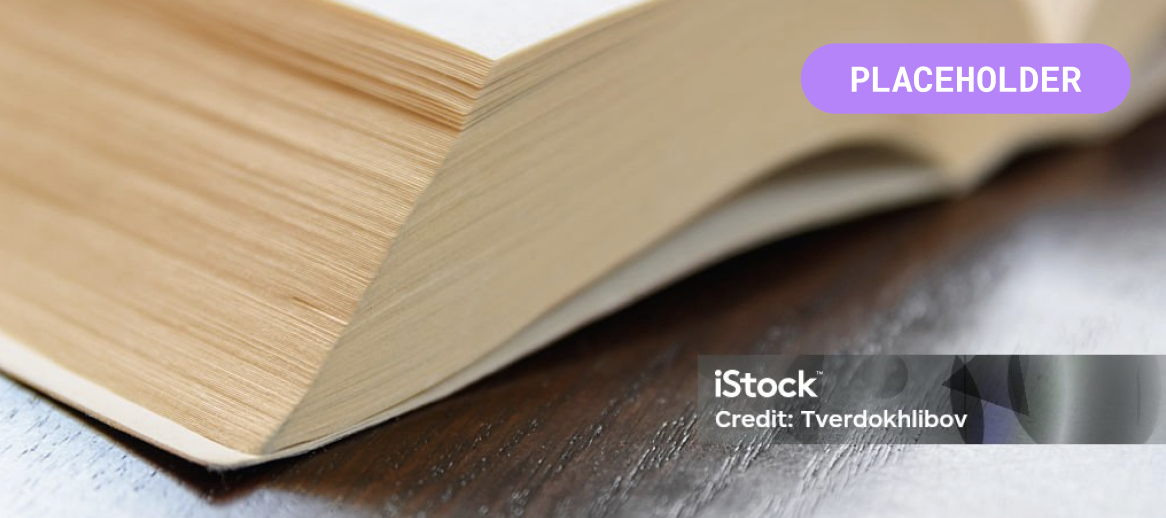Origini e storia dell’opera
Origini e storia dell’opera
La pelike sul lato principale adotta una scena a carattere nunziale-matronale che si svolge su due registri: in alto, una figura femminile di profilo a destra e una coppia di Eroti androgeni con offerte; in quello inferiore, al centro, seduta su una sontuosa kline con cuscini, è una figura femminile con indosso un chitone trasparente ricco di pieghe che solleva con la mano sinistra un lembo del velo; davanti a lei un giovane che le porge un balsamario e, ai lati due figure femminili, quella a sinistra seduta con parasole, stante l’altra davanti a un bruciaprofumi (thymiaterion). In primo piano un cigno allarga le ali. Sul lato secondario, invece, compare una tema di genere con, al centro, una figura femminile seduta di tre quarti tra un giovane stante, nudo con il manto sugli avambracci e un grappolo d'uva nella destra, e una donna panneggiata stante con offerta.
La costruzione su due livelli della scena principale rimanda simbolicamente, per il superiore, alla sfera divina, con Afrodite e i due Eroti che volano sopra la scena umana, con le figure inserite in un contesto nunziale, cui rimanda anche il gesto dello svelamento (anakalypsis) indicativo dello stato di donna sposata della protagonista. Malgrado l’assenza di iscrizioni, alcuni elementi utilizzati per l’iconografia, quali la sontuosità del letto, la ricchezza delle vesti non solo della figura centrale ma anche delle ancelle, uniti alla sobria eleganza dell’intera scena, suggeriscono possa trattarsi di una sposa di rango regale (Elena?), le cui nozze sono poste sotto la protezione di Afrodite.
È probabile, infine, che per forma, soggetto e caratteristiche stilistiche, questa pelike sia stata trafugata da una tomba di ca. metà IV secolo a.C., ubicata in un’area compresa tra la Daunia meridionale (Arpi, Canosa) e la Peucezia settentrionale (Ruvo).
Periodo: 360-340 a.C.
Materiale: Ceramica
Bene recuperato ad opera del Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Origini e storia dell’opera