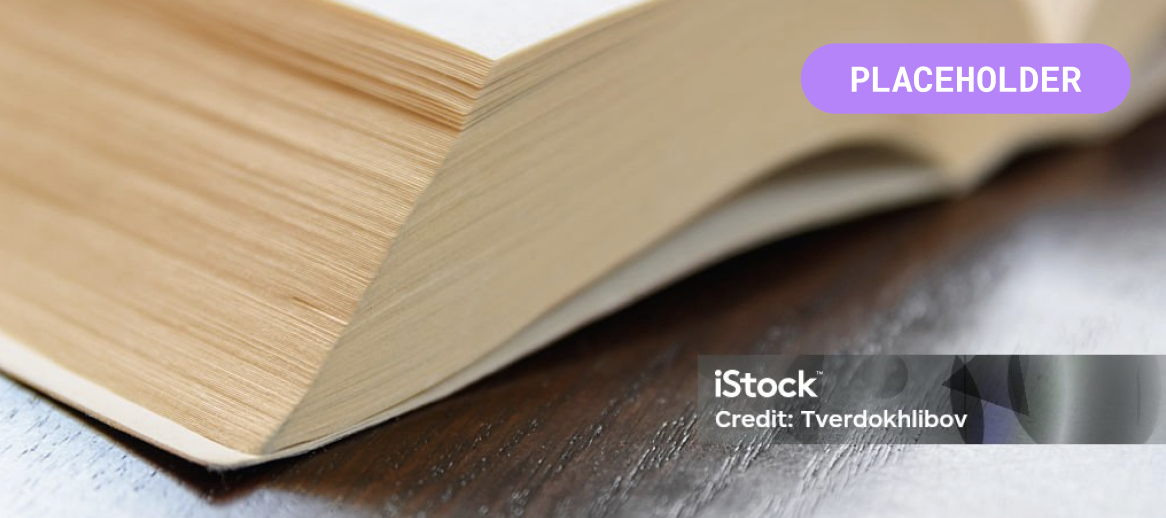Origini e storia dell’opera
Origini e storia dell’opera
Sul lato principale del cratere a calice si svolge su due registri una doppia scena di simposio: in quello superiore sono sette figure maschili semi-panneggiate sdraiate sui letti (klinai), ritratte in conversazione, la seconda delle quali con una kylix in mano; in quello inferiore le figure maschili sono cinque e tre di queste sono rivolte verso un'etera riccamente panneggiata stante tra loro, forse danzante. In entrambi i registri i giovani e gli uomini maturi barbati indossano corone; tavoli e suppellettili tripodate completano la scena del banchetto. Sul lato secondario sono due coppie di figure maschili prive di attributi e anch’esse semi-panneggiate, sedute le due a sinistra, stante e in movimento la figura centrale e ancora seduta quella a destra.
Molto amato dalle aristocrazie di età arcaica è il tema del simposio, il momento del bere insieme durante il banchetto, evento di grande rilievo sociale e occasione privilegiata per rinsaldare i legami di reciprocità aristocratica, esaltare i valori ideologici delle élites dominanti e, in ambito funerario, ostentare il rango del defunto. E questo cratere doveva appartenere a un ricco esponente della società del tempo poiché attribuibile al Gruppo di Polignoto, il ceramografo attico che, assieme al suo Gruppo, è considerato uno dei massimi interpreti di questa iconografia durante la seconda metà del V secolo a.C., fortemente influenzato dalla grande scultura del periodo.
Periodo: 440-420 a.C.
Materiale: Ceramica
Bene recuperato ad opera del Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Origini e storia dell’opera